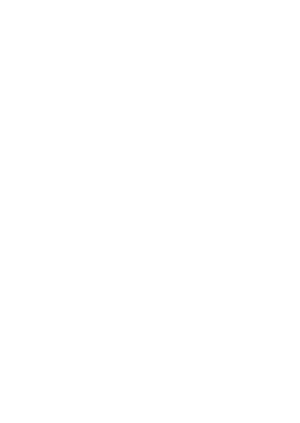Pongo queste domande per avviare una discussione:
- l’attuale cultura manageriale, figlia di una società e di un’economia fondate sul paradigma prestazionale e della forza, può accogliere l’idea di limite come componente costitutiva delle persone, necessaria e non contingente della vita organizzativa?
- é possibile cambiare questo atteggiamento che genera malessere e disuguaglianza, non aprendosi alla possibilità?
- quali benefici arrecherebbe considerare il limite, anziché un fastidioso e frequente accadimento organizzativo, forza vitale ed essenziale dell’agire manageriale?
Per riflettere su tali questioni conviene condividere prima gli usi più frequenti della nostra parola nelle esperienze manageriali. Limite (dal lat. limes-mĭtis) è inteso tipicamente come confine, linea terminale o divisoria, ma è poco usata in verità con questo significato (treccani.it), piuttosto ampio invece è l’uso che se ne fa in un senso più astratto. Ora, comprimendo di molto la realtà, possiamo dire che nel lavoro e nelle pratiche manageriali limite viene inteso primariamente in questi tre modi:
- qualcosa che viene posto per ostacolare l’autonomia del lavoratore con la finalità di segnare i confini del ruolo ricoperto precisandone l’ambito di esercizio;
- una qualche imperfezione della performance di cui viene rilevata la parziale incongruenza rispetto alle attese o a standard, circostanza che la rende pertanto incompleta, non compiuta pienamente, non realizzata come avrebbe dovuto;
- un impedimento al percorso di sviluppo di una persona (per esempio in termini di carriera), riferito alla (rilevata) carenza di competenze necessarie (intese come aggregati di caratteristiche personali, abilità, conoscenze, motivazioni) per poter attualizzare in tale direzione l’impiego del lavoratore.
Il primo modo d’intendere la parola limite nelle esperienze lavorative evoca subito lo strumento della job description, verso il quale si registra da sempre un duplice atteggiamento: da un lato, lo si considera obsoleto perché non rispondente alle esigenze di una realtà organizzativa resa dinamica da continui cambiamenti dei mercati, della tecnologia ecc.; dall’altro, rappresenta sempre il primo ancoraggio a cui ci si appella, in senso generale, per ricercare e valutare persone e il loro contributo. In questo contesto, il termine limite diventa così una sorta di male necessario, perché malgrado porti in dote qualche rigidità e vincoli (insopportabili, per alcuni), appare tuttavia un mezzo per prevenire conflitti organizzativi o per contenere la volontà di potenza dei collaboratori per ricondurli, laddove necessario, nel “seminato”, evitando così che compiano atti che vadano fuori del solco tracciato a presidio dell’ordine organizzativo.
Il secondo modo in cui si usa spesso limite costituisce da sempre materia propria dei colloqui di feedback in occasione della performance review. Evoca per lo più lo stato di difficoltà che i manager possono incontrare nel gestire questi momenti, quando devono condividere le ragioni di una performance che ha presentato qualche limite nella sua realizzazione, non avendone consentito un pieno apprezzamento. In questo caso il limite può diventare (sarebbe auspicabile) il punto da cui partire – dopo aver discusso apertamente le ragioni – per ridare slancio alla prestazione. In questi casi, come si usa dire, il limite è considerato una opportunità di miglioramento e di comprensione più approfondita del contesto della performance.
Il terzo modo, infine, richiama le complesse dinamiche che coinvolgono le decisioni di valorizzare una persona nei contesti di lavoro. Questa volta, il limite si presenta come ostacolo alla crescita del collaboratore, per esempio in ordine all’affidamento di responsabilità più ampie in ruoli che richiedono un profilo non corrispondente a quello posseduto. Di solito è evidenziato dalle mappe di valore delle persone, per lo più costruite intorno all’apprezzamento di perfomance e potenziale, alla base anche delle cosiddette pratiche di talent management. In questo caso, forse, la questione più rilevante è se si considera quel limite gestibile nel tempo, lavorandoci per modificarne la consistenza, oppure no. La risposta positiva, collocandosi nell’orizzonte dello sviluppo, richiederà cura e investimenti organizzativi, per esempio una mobilità professionale, un supporto alla persona tramite programmi di coaching individuale, di mentoring ecc.
Come tirare le fila di questa veloce riflessione? A me pare che non si possa concepire il lavoro manageriale ponendolo fuori dalla realtà del dialogo consapevole con il limite, resterebbe difficile infatti pensarlo nell’essenza del prendersi cura dei collaboratori senza riconoscere che il limite (espressione naturale della finitezza umana) fa parte costitutivamente della esperienza organizzativa. Ostracizzare il limite (quello proprio, dell’altro, dei collaboratori ecc.), facendolo diventare un ingombrante e fastidioso motivo di distrazione per l’occupazione manageriale, significa avere una visione dell’impresa e del lavoro asservita al paradigma prestazionale che fa vedere tutto con le lenti della strumentalità. Significa concepire sé stessi, l’altro, i collaboratori come pezzi da manovrare e far funzionare, non come persone a cui legarsi per realizzare benessere e migliorare la vita.
Ora, pensiamoci bene: non è proprio l’attività di coltivare i limiti, quale occasione di perfezionamento e sviluppo dell’impresa e delle persone, la caratteristica propria e costitutiva del «lavoro manageriale»? Se la togliessimo cosa rimarrebbe del management?
di Gabriele Gabrielli
Coach e consulente, è Ceo di Studio Gabrielli Associati Srl e di People Management Lab S.r.l Società Benefit e B Corp certificata. Ideatore e presidente della Fondazione Lavoroperlapersona ETS, insegna Organizzazione e gestione delle risorse umane e People management all’Università Luiss Guido Carli. All’Università Europea di Roma, dove è direttore del Master in Sustainable HRM è professore a contratto di Remunerazione e gestione delle risorse umane. Il suo ultimo libro è Disegnare e implementare il lavoro sostenibile. Una nuova mentalità per gestire le risorse umane, FrancoAngeli, Milano 2025
Contatti: direzione@peoplemanagementlab.it